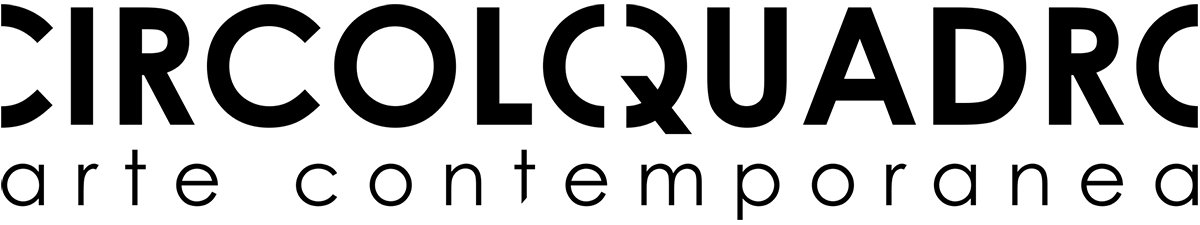di Flavio Arensi
Quando Tolstoj raggiunse su un treno di terza classe Astàpovo, si indirizzò stanco e febbricitante verso i locali poveri della stazione. La sua breve fuga dalla moglie e dalla vita nobiliare – in qualche modo dalla morte interiore – lo condusse al termine di un viaggio di diserzione dalla memoria, di ciò che era o non gradiva più dover essere. Sof’ja (e par ben strano che in fondo un saggio lasci proprio la saggezza) trovò presto il marito, pur impedita nell’avvicinarlo, reclusa a vegliare il lume fioco della stanza dai finestrini di una carrozza abbandonata su un binario destituito. Le fu permesso di abbracciarlo quando ormai Tolstoj giaceva in un coma convulso e freddo, lui simbolo rattrappito di speranze postcristiane, lei ancora baluardo di una società costituita: sic transit gloria mundi. In fondo, non è questo il medesimo, stretto, orizzonte da cui scappa Drogo, misurando passo dopo passo la sua Fortezza, in attesa dei nemici forestieri? Buzzati narrò le lunghe giornate del tenente negli uffici larghi di via Solferino, osservando i colleghi giornalisti invecchiare, di alcuni fallire le speranze o le ambizioni di carriera, finanche le certezze, così attendere a qualcosa che non giunge, né mai arriva a compimento. In questo modo oscilla l’uomo, la cui esistenza si svolge in un campo di scelte, di decisioni fra diverse alternative plausibili dove la possibilità, e non la necessità, caratterizza la sua presa temporale sul mondo, nella perenne instabilità del vivere. Questa instabilità ci costringe a segnare i nostri baluardi, erigere le statue dei nostri condottieri o celebrare chissà quale monumentale costruzione che racconti di una grandezza destinata, presto o tardi, a deperire.
Massimo dalla Pola ha sempre dissacrato le vanità dell’uomo – forse le utopie – e nel ciclo «Il sole dei morti» del 2014 scrive il diario di viaggio fra le miserie eccezionali della nostra specie, che significa transitare per i memoriali delle ideologie, i loro palazzi, le loro statue, i loro templi eretti per celebrare una temporalità che si crede eterna, ma che sfiorisce come sfioriscono le rose. Vi era già stato nel 2013 il tentativo di connettere il paesaggio al significato degli accadimenti lì occorsi, le stragi, i misteri, le complesse perifrasi della storia che susseguivano in Italia e in Europa come condizione di una società votata retoricamente a eternare i gesti, anche i peggiori, o la loro consacrazione, in termini di topos (appunto luoghi); e intanto però non indagarne le ragioni o scoprirne le colpe. Come dire: piangiamo il morto, ma se fa comodo nascondiamo l’assassino.
Con i nuovi lavori de «L’incendio» il passo è ulteriore, non vi è l’impalpabile presenza dei fatti di cronaca a segnare lo spazio, né l’idealizzazione di un concetto che si struttura in forma architettonica. Piuttosto, è lo sgretolarsi coercitivo di quanto la storia ha prodotto, il radere le basi dell’ossessione che ogni generazione si porta sulle spalle per restare inalterata e inalterabile. Siccome l’uomo non ha mai cessato di ripetere i propri sbagli, ammantandoli di matrici sacrali o religiose, nascondendo i delitti fra le increspature delle palandrane da liturgia, può anche capitare di non stupirsi dell’efferatezza con cui, in questi anni recenti, i fondamentalisti islamici cancellano la memoria millenaria distruggendo le vestigia archeologiche di culture lontane. Perché, in ultimo, pochi si fermano a osservare gli eventi e se succede si scorgono marciare lontani i barbari bianchi mentre annoiati ci si strugge, come Verlaine, dall’alto di una rupe, «componendo acrostici indolenti in aureo stile in cui danza il languore del sole»: che detta in poesia rende interessante anche la peggior disavventura. D’altronde, a Puebla, in Messico, l’ombra delle sue cento piramidi fu di colpo sostituita da quella smilza e singolare di cento campanili, con croci, campane e un meticcio per sacristano. Insomma, tutto passa o tutto passerà, e se così non fosse a qualcosa bisogna pur votarsi, al santo, al comandante, al maître à penser: l’In·tel·let·tu·à·le. Così nelle Americhe gli invasori cristiani prima cancellarono i simboli della cultura autoctona, poi ne imposero di nuovi erigendo i propri monumenti all’eternità: ancora oggi si celebra in grande pompa l’arrivo di Colon (Colombo) il liberatore e il popolo dei conquistati festeggia il popolo dei conquistatori: questione di saper ben raccontare e vendere un prodotto credibile che non lasci nostalgie o languori. Cadono i Buddha in pietra, cedono le porte secolari dei persiani, rotolano le rovine di Samarra sotto i colpi di chi intende devastare i ricordi di qualcosa che chissà quando eravamo, e che oggi non siam più se non nelle cartoline per turisti a buon mercato.
Dalla Pola non ha bisogno di entrare nel dettaglio, non gli serve elencare i danni, le decapitazioni, i segni del maltolto – che poi i Francesi spararono al naso della Sfinge e in Brianza gli architetti han spazzato le cascine per farne condomini per zanzare; il segno secco delle sagome, il nero pece che inghiotte le forme staglia contro il rame denso e pastoso dei cieli, incombenti, come il fuoco fra le rovine. Quando aveva iniziato i suoi lavori dorati, la preziosità luminosa riempiva di senso perentorio il valore dell’immagine, offriva all’occhio il linguaggio, anzi il verbo, di un oltremondo sacro, come i fondi di Cimabue che alza il volto al divino, prima della caduta a terra del realismo giottesco. Il rame, invece porta con sé l’odore del pentolame antico, da cucina rurale e crotto montano, quello insomma da dover lucidare per non farlo annerire. Perché il rame si sporca, diventa torvo, come la fuliggine che copre i ceppi ancora brulicanti di fuoco, e quel nero che sarà, adesso è sfavillante, è pieno di rosso e di una luce che non irradia ma assorbe, muta, e pian piano si spegne. Vi è dunque in questi lavori il senso estremo di un mutamento, di un passaggio che sancisce il cambiare di stato, il costruire e lo smontare, il fuggire e il permanere, perché così sono i cambiamenti sociali, la civilizzazione che non è più società, il tramonto infuocato e la notte. A un certo punto della vita a tutti vien da dire di conoscere la verità dei fatti, di conservare il registro delle soluzioni e preme spesso per imporre il proprio sentiero come il giusto cammino. Rimane per certi versi la necessità di dover insegnare, essere il maestro che scuote l’albero delle menzogne e sancisce la retta via. In tal modo, queste orde di barbari neri, alla fine del nostro impero, sparano e bombardano i segni di una bellezza antica, di un sapere che non ci appartiene, ma stabile sorvegliava chi passava e arrivava. Come i Tartari, tristemente ai cancelli, come il treno fermo a Astàpovo, quel che è stato non c’è più; intanto brucia da Aleppo a Bagdad l’incendio velleitario di altrettante superbe vanità.
***
Mostre correlate